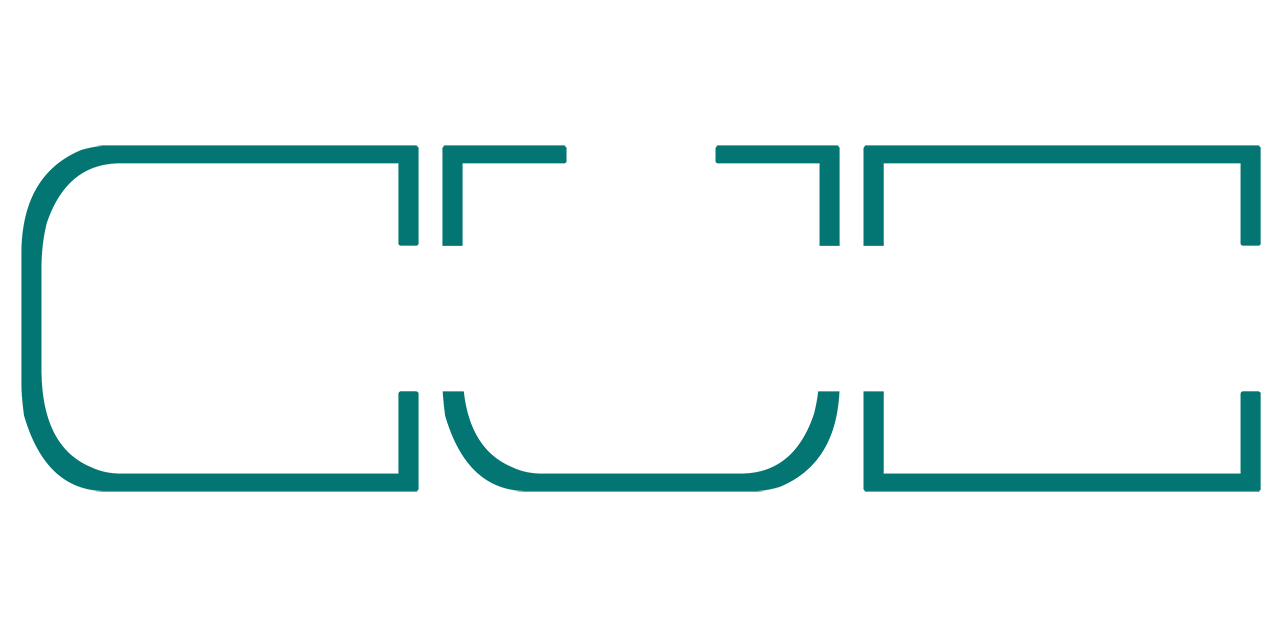Intervista al Professor Amato 3: franco CFA e cambi fissi

Continuiamo con l’intervista al Professor Massimo Amato. In questa terza parte parliamo degli scenari possibili che un’economia potrebbe fronteggiare se decidesse di abbandonare il sistema del franco CFA. Inoltre, approfondiamo il tema dei cambi fissi.
Ammesso che lo Zimbabwe non utilizza il franco CFA, sappiamo che attualmente viaggia in iperinflazione;
tra le varie teorie, Lei, generalmente, ritiene sarebbe meglio abbandonare il franco CFA, entrare o
rientrare? O magari come l’Euro, come molti pensano, entrare è stato un errore ma uscirne sarebbe peggio?
In realtà bisogna avere la pazienza e il coraggio, politico e intellettuale, di ammettere che siamo in una fase in cui tutte le opzioni devono essere valutate. I problemi di sviluppo, demografici, monetari e geopolitici investono tutta l’Africa, non solo i paesi del CFA ma anche tutti i Paesi che volessero entrare in una unione monetaria non più a dominanza francese. Penso alla Nigeria: è un paese anglofono, non ha una tradizione di rapporti particolarmente forti con la Francia e probabilmente non avrebbe interesse ad entrare, in questo momento, essendo un forte esportatore di petrolio, in un sistema che rischia di
penalizzarla proprio per il suo ancoraggio all’Euro. Ma potrebbe entrare in un’altra unione monetaria.
In linea generale, secondo me, la questione è quella di non sottrarsi a nessuna ipotesi quantomeno in linea di principio. La posta in gioco qual è? E’ quella che il mio amico economista togolese Kako Nubupko chiama, da qualche settimana a questa parte, un’uscita “ordinata e coordinata” dagli assetti monetari precedenti. Questi assetti cristallizzano rapporti che non sono solo rapporti di forza, ma anche di convenienza reciproca. La vera questione è: questa cristallizzazione corrisponde ancora ai fondamentali delle economie chiamate in causa? Oppure la situazione geopolitica è talmente cambiata che, evidentemente, bisognerà anche rivedere gli accordi che la rendono operativa? Questa è l’unica questione.
Dal mio punto di vista, “uscita ordinata” significa valutazione attenta di tutte le possibili alternative; “uscita coordinata” significa invece che un’uscita che dia uno spazio politico decisionale maggiore ai Paesi implicati, ma che non possa escludere i Paesi e le istituzioni che, finora, si sono occupate di mantenere l’ordine costituito. Per esempio, la Francia per quanto riguarda il franco CFA ma, più in generale, il Fondo Monetario Internazionale, e infine l’Unione Europea, non foss’altro per via dell’ancoraggio del CFA all’euro. Gli assetti attuali, monetari ed economici, dell’Africa sono stati decisi strategicamente attorno agli anni ’90, dopo la caduta del muro di Berlino, quindi con la partenza della globalizzazione che, in quegli anni, si pensava monocentricamente come “westernization”.
E’ chiaro che una serie di decisioni e compromessi e alchimie istituzionali sono state fatte sulla base di ipotesi. Ora, quell’ipotesi è saltata, nei fatti, perché siamo in una situazione policentrica in cui il “West” continua a pesare ma non ha più una posizione egemonica esclusiva. Si tratta di ricontrattare tutti i rapporti fra tutti gli attori e, forse, anche di cambiare i metodi con cui si arriva alla soluzione dei problemi implicati da tali rapporti.
Passiamo all’esperienza dei tassi fissi. Se ci fosse un controllo da parte dello Stato più forte, perché Stati
come la Svizzera o la Repubblica Ceca, hanno deliberatamente deciso di adottare il cambio fisso e poi, però,
ne sono usciti? Si veda franco svizzero 1,20 con euro o 1 euro 25 corone.
Sono tutte politiche reversibili. Quando si fa una politica di tassi fissi, bisogna fare i conti con la finitezza delle riserve valutarie. Perché possa essere mantenuto nel tempo, un tasso fisso deve essere fissato in modo che sia difendibile, il che implica ovviamente anche la questione del posizionamento del paese in questione nel commercio internazionale. E’ chiaro, infatti, che la speculazione valutaria è fatta in modo tale da scontare la difendibilità dei tassi. Se un tasso appare come non difendibile, viene attaccato e risulta, di fatto, non difendibile perché viene attaccato, nel senso che non c’è una quantità di riserve che possa salvarlo.
In questo campo, come del resto in molti altri, io sono per evitare le polarizzazioni. Non si tratta di opporre tassi incondizionatamente fissi a tassi incondizionatamente variabili: si tratta di capire in quale ordinamento monetario si vogliono far entrare i rapporti tra Stati. Perché un’altra ipotesi che, dal mio punto di vista, è molto più interessante sia dei tassi fissi che dei tassi variabili è l’ipotesi dei cambi aggiustabili. I cambi aggiustabili hanno a che fare con unioni monetarie come quella di Bretton Woods. Non mi riferisco solo a quella effettiva, uscita dalla conferenza del 1944, ma soprattutto al progetto di Keynes di una “International Clearing Union”. Tassi aggiustabili sono stati utilizzati durante l’esperimento, riuscito e felice, dell’Unione Europea dei pagamenti, fra 1950 e 1958.
Qual è l’idea? Che il tasso di cambio fra una moneta nazionale e la moneta internazionale usata per regolare gli scambi commerciali internazionali deve poter variare in relazione alla necessità di aggiustare le ragioni del cambio. In un’architettura monetaria in cui i movimenti di capitale di portafoglio non hanno la possibilità di creare distorsioni, i tassi devono semplicemente adattarsi alle condizioni dello scambio commerciale fra Paesi e, nell’orizzonte di una camera di compensazione e di un accordo basato sulla multilateralità, l’unica posizione di lungo periodo possibile per ogni economia è quella di equilibrio della bilancia commerciale.
Questo significa che non solo i deficit strutturali sono un problema, giacché, evidentemente, portano all’indifendibilità del cambio o, qualora non ci sia più il cambio, alla necessità di politiche deflattive. In questa logica, anche i surplus sono un problema, simmetrico ma di eguale importanza e peso. Siccome non possiamo forzare tutti i Paesi in surplus a rivalutare al di fuori di questi accordi di commercio multilaterale, ecco perché tali accordi si rivelano fondamentali quando la posta in gioco sia il riassorbimento degli squilibri commerciali e non il loro perpetuo finanziamento e rifinanziamento. Nella misura in cui il multilateralismo e la cooperazione venissero riconosciuti come basi del commercio internazionale, apparirebbe evidente che la scelta più efficiente è quella dei cambi aggiustabili, all’interno però di accordi di compensazione multilaterale.
Altrimenti i movimenti speculativi di capitale potrebbero sempre impedire il raggiungimento della posizione di equilibrio di lungo periodo. Cioè, renderebbero possibile ciò che hanno reso possibile negli ultimi 30 anni: i “global imbalances”, e quindi crescite tanto drogate quanto il rischio di depressioni prolungate. i “ritmi cinesi” della Cina sono anche legati al fatto che quel Paese difende da tempo un cambio fisso, ma sottovalutato. Questo ha fatto la Cina: il cambio è fisso, ma non è al livello di equilibrio; resta cioè a un livello tale da consentire, di fatto, una competitività che passa per ragioni monetarie e non produttive.
All’interno di una logica di compensazione multilaterale, questa posizione non potrebbe essere tenuta indefinitamente perché l’accumulazione indefinita di surplus è sanzionata. Questa dovrebbe già valere, in teoria, per l’Europa nella misura in cui la “Procedura per gli squilibri macroeconomici” ha sanzionato l’accumulazione strutturale di surplus come potenzialmente foriera di disequilibrio.
E’ di ieri ( 24 Febbraio) un articolo de “Il Sole 24 Ore” che dice che la Germania ha un rapporto surplus/Pil abnorme, che non ha paragoni con nessun’altra economia. Ma ancora di più che lo squilibrio in sé, l’articolo giustamente sottolinea un altro fatto: quello che potrebbe apparire alla Germania un tratto della sua forza è, invece, un tratto della sua debolezza, ossia della sua dipendenza dal ciclo economico internazionale. Una Germania che si trovasse a fronteggiare una caduta della domanda internazionale, entrerebbe in una recessione dalla quale non sarebbe facile uscire, con effetti a catena sulle filiere produttive che vedono la Germania come elemento centrale.